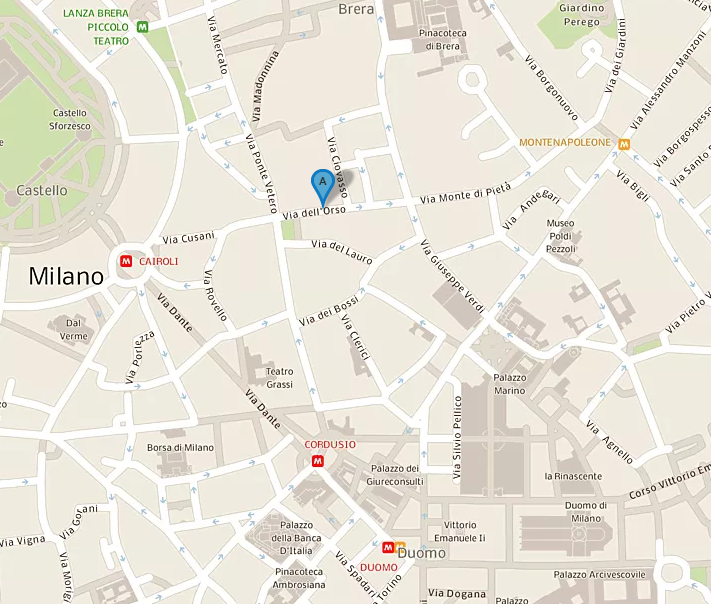De Albertis Sebastiano
Milano, 1828 - Milano, 1897
"Soldato a cavallo"
Olio su tavola, cm 21x14
Firmato in basso a destra: "De Albertis".
Francesco Milizia, teorico e banditore del neoclassicismo, dava addosso furiosamente ai battaglisti secenteschi e settecenteschi: “gli artisti ricavano quelle scene di orrore dalle Storie, dalle Poesie, dai Romanzi; ma né Romanzieri, né Poeti, né Storici, né Pittori han veduto Battaglie; e gli spettatori che neppure ne hanno viste ammirano quelle scene pittoresche. Basta che il sangue vi si versi a torrenti, che vi siano confusioni, movimenti, ferite orrende, cadute, convulsioni, crudeltà, barbarie, spaventi, intrepidezze incredibili. Non importa poi che masse di rosso e di giallo siano gettate a caso per rassembrare il fuoco del cannone e della moschetteria; ciò è niente; che i cavalli non siano cavalli, ma bestie chimeriche, che i combattenti non siano più uomini e che tanti altri oggetti siano indicati per segni, come se la pittura fosse un’arte di geroglifici”. “Chi ha la vocazione per le battaglie vada a vederle con sangue freddo, le osservi attentamente e poi le dipinga. Se questa maniera di studiare non accomoda, studi almeno l’anatomia degli uomini e delle bestie, e nel fuoco dell’azione non perda di vista i principii del disegno, del colorito, della vera armonia. Su questi inviolabili principii sono le battaglie”. Il consiglio del Milizia fu ascoltato, ed ebbe una preziosa applicazione nei tempi in cui furono vissute le appassionate vicende delle guerre del Risorgimento quando svariati pittori ne seguirono le gesta, ne vissero gli entusiasmi e gli scoramenti, giudicando la pittoricità dei soggetti con una serenità attraverso la quale essi stessi vivendola potettero cogliere la freschezza di alcuni atti e di alcuni fatti, nonché l’impeto e l’eroismo di altri. Fu ad essi possibile a volte di riuscire di una capacità documentaria squisita, a volte di essere commossi da una cordialità limpida, a volte di elevarsi alla solennità dei fatti, e alle magnifiche furie della battaglia. Indubbiamente, l’ispirazione di Vernet, di Delacroix, di Messonnier e di tutti i pittori francesi che rivissero le glorie epiche della leggenda napoleonica, discese rapida ai pittori italiani che contribuirono, una volta unita la Patria, a glorificare le imprese e gli aspetti di un esercito che si era dimostrato degnissimo dell’amore delle popolazioni, per il sangue versato, per la nobiltà del suo contegno vivo in ricordi entusiastici. Sebastiano De Albertis fu tra coloro che sentirono con più commosso ani¬mo il contatto con la vita eroica della guerra, e lo diffuse accanto a sottili seduzioni della vita elegante di cavalieri e di dame, e a caricature sobrie ed essenziali. La sua spigliatezza spontanea trovò consenso tra gli stessi scrittori che difesero la riforma cremoniana cercando di demolire quanti le erano avversi, infatti valutarono la sua nobile fatica con parole serene e cordiali. De Albertis, giovanissimo, depose il pennello a Brera per impugnare in piazza il fucile della rivoluzione: egli fu con Manara alle barricate della sua Milano nel marzo del 1848, per partecipare poi a tutte le campagne della guerra d’indipendenza. Ed ecco come si rivela il segreto dei suoi dipinti, delle sue cariche, dei suoi cavalli, delle sue battaglie, dei suoi militi; delle sue tele, che grandi e piccole illustrarono eloquentemente le campagne del nostro Risorgimento: “Egli raggiungeva un gran magistero nell’arte, perché tramandava alla gloria ciò che aveva veduto; perché faceva rivivere delle pagine che egli aveva vissuto. E il magistero consisteva appunto nel movimento, nella vita, nel vero, nel sentimento altamente patriottico”. Della sua attività iniziale lo stesso De Albertis non tenne nessun conto, e volle che la sua opera fosse considerata come principata nel 1872, periodo in cui, anche a nostro avviso, egli si era impadronito di una forma pittorica, che parve conciliare le diverse forme che il suo commilitone Eleuterio Pagliano, gli Induno e gli innovatori del gruppo cremoniano misero in luce. Il tumulto dei campi di battaglia, delle scene di guerra, gli si fece meglio e più profondamente presente, quando la sola sua fantasia ne rievocava la memo¬ria, e la sua opera pittorica più pura e più vera nacque da una purificazione dei fatti veduti e vissuti, rievocati quando gli avvenimenti non erano più se non una ricostruzione ideale, liberata da quanto aveva di materiale e di impuro, e poteva tradursi in una visione limpida, nuova, originale di entusiasmo e di bellezza. Obbedendo al solo impulso di espandere l’esuberanza dell’animo, il De Albertis si sente veramente padrone di sé, in un certo senso egli sembra così sfuggire alle più dirette efficace lombarde, che lo portano alla scelta delle coloriture chiare, un po’ aride, nelle quali era possibile inserire le linee vibranti di un disegno agile, vivo, tutto fervore di movimento, di scorci, di audace. In più il senso dell’aria aperta, così difficile da definire, gli riesce agevole e sincero; la composizione è viva e commossa, con un tono di tragedia eroica che dà un inimitabile descrizione poetica delle corse sfrenate al galoppo, degli arrancanti cavalli attaccati ai cannoni, degli equipaggi con le bestie quasi impennate in scarti degli scompigli delle pariglie, delle cadute di cavalli e dei lanci di cavalleria che prendevano con grande emozione la fantasia di chi osservava la sua opera: Luigi Archinti notava, con un giudizio che oggi noi confermiamo, che l’eleganza del De Albertis “faceva spiccare la rozzezza antipatica delle Ordinanze del Fattori, forte pittore militare, ma col guaio di improntare nei soldati dei tangheri che toccano il grottesco per raggiungere il tipo del soldato scarpone”. E. Motta